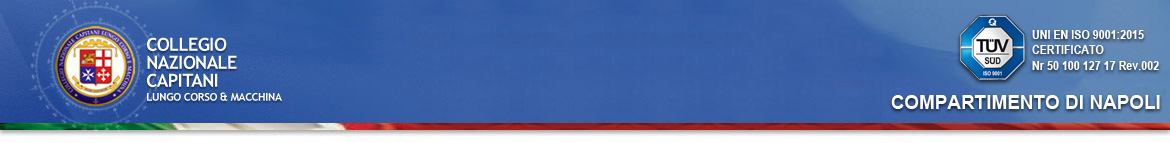Diversificare male. Analisi della fine di Hanjin
Articolo di giovedì 22 dicembre 2016
Nel corso dei mesi recenti si è scritto molto sul “caso Hanjin” e, come
al solito, si è posta l’attenzione sull’aspetto mediatico (navi e
carichi bloccati in rada, retailers disperati, consumatori di
elettronica sull’orlo del suicidio per mancanza di prodotto).
di Fabrizio Vettosi
Non sono mancati soloni, moralisti e relativi commenti sul fatto che Hanjin sarebbe un’azienda di Stato vestita da entità privata, come se non lo fosse anche Fincantieri - giusto per fare un esempio vicino - oppure Chantier de l’Atlantique in Francia. D’altro canto, chi ne sa di shipping, e in buona fede, sa benissimo che quasi tutti i principali carriers rivestono un ruolo sistemico nei rispettivi Paesi. Personalmente ho avuto modo, nel corso della mia attività, di avere rapporti con Maersk, Evergreen, Zim, e in tutti questi casi ho potuto verificare tale aspetto. Andate a vedere quanto pesa in ciascun prodotto interno lordo nazionale l’attività di questi soggetti. Abbandonando il tono serioso, posso testimoniare che una volta, trovandomi a rendere visita a Sammy Ofer (magnate di Zim, ndr), ho rischiato di essere arrestato all’aeroporto di Tel Aviv in quanto al mio arrivo, ad una domanda postami dalla sicurezza, affermai che ero in visita al signor Ofer. La risposta fu: «Lei non sa da chi sta andando», ciò per sottolineare la sensibilità del Paese verso il soggetto.
Tornando ad Hanjin, si è posto l’accento sulla più o meno solita e risaputa “litania” della concentrazione come unica panacea alla risoluzione dei problemi, sino a che uno principali giornali internazionali di shipping (che come al solito preferisce il sensazionalismo al tecnicismo) ha azzardato una raffigurazione “macabra” della situazione titolando il caso con la frase “Quattro matrimoni e un funerale", come il celebre film britannico. Nessuno si è, tuttavia, preso l’onere di andare a fondo dell’argomento per cercare di capire le cause che hanno generato il dissesto, se questo era evitabile e quali saranno le conseguenze.
Sostanzialmente si trattava di fare una diagnosi e, di conseguenza, di “sporcarsi le mani” in un lavoro di ristrutturazione abbastanza estenuante e con conseguenze politiche nell’ambito del Paese. Una sorta di “caso Alitalia” ma ben più facile da risolvere. Sì, sembrerà paradossale, ma mentre il caso Alitalia vede quale elemento centrale della “patologia” ancora l’eccessivo peso della macchina “centrale” (personale), nel caso di Hanjin siamo di fronte ad un mix di errori di carattere finanziario e strategico che non pertengono al “core business” storico o quello che sarebbe dovuto essere negli anni: il container.
Diversificare nei settori sbagliati
Iniziamo con un grafico esemplificativo che ci dice come, in sintesi, la concentrazione dei primi dieci carriers non sia mutata in maniera decisiva nell'ultimo decennio, solo negli ultimi anni (o mesi) si è riscontrato un incremento sostanziale.
In molti si concentrano su tale dato dimenticando che da solo dice poco. Infatti, ancora oggi la metà delle portacontainer è controllata da “armatori puri” che le noleggiano poi a caricatori che si accollano il rischio operativo e devono remunerare i costi finanziari (spesso salati, e ben più alti degli interessi espliciti) agli armatori. Quindi dire, per esempio, che Marsk ha 224 navi, Msc 200 e Hanjin 38 significa davvero poco, è molto più importante sapere quante navi operano. Il caso di Hanjin è per me emblematico. Analizzando i bilanci dal 2006 ad oggi ho potuto calcolare il tasso di impiego della flotta propria rispetto al volume di carico, arrivando a scoprire che nel 2006 solo il 35 per cento del trade veniva fatto con navi proprie, mentre nel 2015 questa percentuale era salita a circa il 45. Ciò ci da una prima risposta, ovvero che Hanjin ha agito più da operatore che da armatore pagando oneri elevati agli owners e gestendo male il rapporto con questi. D’altro canto la flotta-container Hanjin è stata da sempre relativamente piccola (da 28 navi nel 2006 a 39 navi nel 2016) ancorché quasi integralmente rinnovata nell’ultimo decennio con la sostituzione delle vecchie post-panamax con le nuove new panamax. Ma il dato che maggiormente colpisce chi come me fa l’analista e si occupa di ristrutturazioni è che Hanjin non ha mai smesso di essere un colosso diversificato nelle più svariate forme di traffico “tramp” (quello che non ha un servizio regolare o non pubblica i porti di approdo). Nel 2006 il traffico di prodotti alla rinfusa e liquidi era ben oltre le 40 milioni di tonnellate, nel 2015 sopra i 20 milioni. Nel corso dell’ultimo decennio Hanjin ha investito circa 900 milioni di dollari in portarinfuse e cisterne (incluse quattro chemical carrier che con i container c’entrano davvero poco). In particolare, dai miei calcoli risulta che solo un quarto dell'attività commerciale è stata realizzata con navi proprie mentre la maggior parte attraverso navi di terzi. Si arguisce che Hanjin (come forse noto ai più) è stato un aggressivo operatore nel segmento secco e liquido nel periodo più nefasto della storia dello shipping per entrambi i settori, seppur con momenti alterni. Tutto ciò ha causato un drenaggio di risorse finanziarie generate dall’attività container che anche nei momenti peggiori ha generato dei flussi di cassa operativi positivi. A ciò aggiungasi gli ulteriori investimenti in altre attività che, seppur diversificate (vedi i terminal), hanno un minimo di connessione operativa con i container.
Cattiva gestione finanziaria
Non manca, evidentemente come sempre, la “ciliegina” rappresentata dalla scarsa capacità del management in chiave finanziaria. È evidente, dall’analisi approfondita dei bilanci dell’ultimo decennio, che gran parte del nuovo debito, ed il rinnovo del vecchio, si è formato ed è cresciuto nell’ultimo quinquennio. In questa fase il management di Hanjin è stato piuttosto inerme, limitandosi a gestire i rapporti soprattutto con enti locali e concentrando le scadenze tutte o quasi tra il 2016 ed il 2017. Una morte annunciata dettata dall’incapacità di gestire l'aspetto finanziario. Il grafico 2 [alla fine dell'articolo] rende bene il concetto.
Tale incapacità è ancor più evidente laddove si consideri gli elevati tassi di interesse corrisposti ai finanziatori (i soliti “soggetti domestici”). Da calcoli più o meno precisi tale ammontare sfiora i 2 miliardi di dollari nel decennio 2006-2016.
In conclusione, se fosse stata intrapresa un’aggressiva strategia di diversificazione con una progressiva delocalizzazione dal core business (container), nonostante la problematica gestione dei rapporti con gli armatori, attraverso il cash-flow operativo prodotto (circa 4,3 miliardi di dollari, tra l’altro inclusivo delle perdite sul carico liquido e secco) Hanjin sarebbe riuscita: a soddisfare le proprie esigenze di rinnovo della propria flotta container; probabilmente a pagare gli interessi sul debito, che sarebbero stati sicuramente più bassi e meglio negoziati; nonché ad avere un ulteriore “buffer” a disposizione per la ristrutturazione del debito residuo.
Probabilmente, il monito che ci viene da questa analisi è che ormai anche il modello della “conglomerata” (che tutto fa e tutto sa fare) è inadeguato in un contesto sistemico in cui ogni attività predittiva è messa in crisi dal mutare costante delle variabili.